Viaggio tra le opere di Cesare Pavese
L’unico modo per conoscere uno scrittore, si dice, è seguire la scia d’inchiostro che si lascia dietro. I libri che mette al mondo al posto dei figli. Ma per capire a fondo uno scrittore non basta leggerlo sulla carta.
Serve scavare fra le righe infinite, leggere gli spazi bianchi tra di esse, tentare di recuperare ciò che la sua mano spietata ha estromesso dalla pagina e studiarlo con lo stesso rigore con cui si indagano gli antichi, lontani, pieni di misteri, sospesi nelle pieghe infinite del tempo andato. Ecco come cercherò di indagare Cesare Pavese, come lui fece con gli antichi, fra le traduzioni di Omero e i Dialoghi con Leucò.

Cesare Pavese e l’antico: i Dialoghi con Leucò
Cesare Pavese è indubbiamente uno dei più grandi narratori italiani che il secolo breve ci abbia regalato.
Nell’arco della sua vita, interrotta troppo presto nel 1950, scrive innumerevoli opere, misurandosi con una pletora di generi diversi tra romanzi, epistolari, saggi, raccolte poetiche, persino sceneggiature e alla fine, a pochi anni dalla sua tragica morte, torna alle origini – sue e della letteratura occidentale – e decide di misurarsi con l’antico: nascono così i Dialoghi con Leucò e la traduzione dell’Iliade.
Due opere preziose più delle altre perché, contornate da una pletora di lettere, commenti, e analisi dell’autore stesso, gettano una luce particolare tanto sul Pavese editore e scrittore, quanto su Cesare, sull’uomo.
Nell’introduzione alla prima edizione di Dialoghi con Leucò, Pavese scrive:
“Cesare Pavese, che molti si ostinano a considerare un testardo narratore realista, specializzato in campagne e periferie americano-piemontesi, ci scopre in questi Dialoghi un nuovo aspetto del suo temperamento. […] Pavese si è ricordato di quand’era a scuola e di quel che leggeva: si è ricordato dei libri che legge ogni giorno, degli unici libri che legge. Ha smesso per un momento di credere che il suo totem e tabù, i suoi selvaggi, gli spiriti della vegetazione, l’assassinio rituale, la sfera mitica e il culto dei morti, fossero inutili bizzarrie e ha voluto cercare in essi il segreto di qualcosa che tutti ricordano, tutti ammirano un po’ straccamente e ci sbadigliano un sorriso. E ne sono nati questi Dialoghi.”
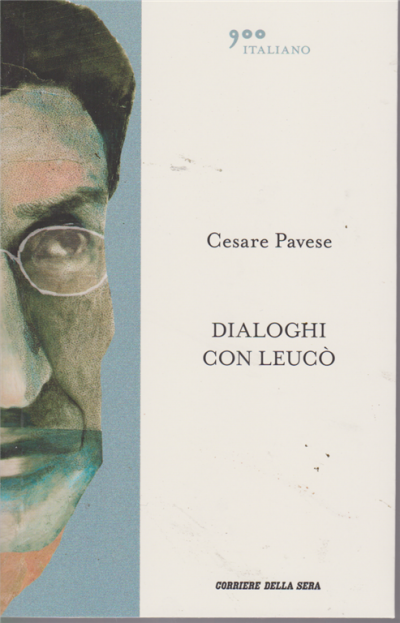
Sin dalle righe iniziali di questo suo primo – pubblico – approccio con l’antico, apprendiamo che per lui non è soltanto un esercizio di stile o un’ostentazione di cultura, ma nasconde qualcosa di più profondo, quasi una necessità.
L’opera consta di ventisette dialoghi tra personaggi tutti rigorosamente del mito greco. All’inizio gli interlocutori sono entità naturali come la Nube, concetti astratti come Thanatos o Eros, o mostri come Chirone e, man mano che procediamo, il loro posto è preso dagli dei “tradizionali” e dai personaggi più noti della mitologia.
Caratteristiche dell’opera
È pubblicata nel 1947, in un periodo particolare per la nostra stanca Italia: un secondo dopoguerra in cui imperava la corrente neo-realista, quasi come risposta alle atrocità di un conflitto durante il quale su troppe cose si era fatto finta di niente. Il neo-realismo, con il quale Pavese stesso si era misurato pubblicando opere come Il compagno e La luna e i falò, era il tentativo degli intellettuali di non voltarsi dall’altro lato, di guardare in faccia i problemi del nostro Paese.
Eppure, con questo libretto, Pavese pare senta il bisogno di evadere da questa realtà tanto indagata. Ma è davvero così? Molti hanno commentato l’opera, sostenendo che l’unico intento dell’autore fosse analizzare l’evoluzione della vita dell’uomo dal caos della Natura libera da condizionamenti alla legge razionale di Zeus, facendo un’analisi del mito come bagaglio culturale comune della civiltà occidentale. Invece, leggendo l’opera, la sensazione è che Pavese non si allontani dalla realtà, anzi, pare si addentri progressivamente nel suo cuore, allargando, riga dopo riga, lo strappo nel cielo di carta.
Egli si era reso conto che la realtà era molto più atroce di quanto gli scrittori stessi potessero esprimere semplicemente descrivendola: nascondeva cose che la letteratura non poteva esprimere. Non da sola. Così era accorso in aiuto dello scrittore il mito. Quel linguaggio atavico fatto di immagini e filosofia con cui da sempre l’uomo cerca di spiegarsi ciò che la ragione afferra, sfiora, ma non sa esprimere. È la risposta dei poeti ai problemi insolubili degli scienziati. Pavese lo sapeva, così quando la bestialità dell’uomo e l’irrazionalità della sua vita cominciarono a mostrarsi, egli tornò da loro, interrogò le bestie, la morte, l’amore, i principi irrazionali, tentando di spiegarsi la realtà.

La fredda accoglienza dei Dialoghi con Leucò
In un mondo letterario dominato dalla corrente neo-realista, dunque, i Dialoghi non potevano che essere accolti per lo meno con freddezza. Pavese doveva aspettarselo, ma ne fu comunque deluso, tanto che in una lettera a Tullio e Cristina Pinelli scrive:
“[I Dialoghi con Leucò] non piacciono a nessuno, tranne che a un valente professore di greco e studioso di religioni che mi ha subito regalato un suo estratto, Il concetto di daimon in Omero, con questa dedica: “A Cesare Pavese, l’artista interprete della religione ellenica.”
Il valente professore di greco era Mario Untersteiner, allora preside del liceo Berchetdi Milano con il quale per mesi Pavese tenne un fittissimo epistolario che lo entusiasmò a tal punto da riesumare un suo vecchio progetto. A lui, sempre nel 1947, scrive:
“Caro Professore, ho la sua e il numero (l’ultimo ohimè!) dell’Educazione Politica.
Adesso una proposta. Da parte di Einaudi. È da molto tempo che io sogno di vedere stampata una versione quasi letterale verso a verso, andando a capo quando il senso è finito dell’Iliade e dell’Odissea (il corsivo è mio). […]”
Il progetto fu accolto con entusiasmo, ma Understeiner non accettò di portarlo avanti personalmente. Propose però a Pavese l’aiuto di una sua brillante allieva, Rosa Calzecchi Onesti. La proposta fu vincente e così, nel 1950, dalle quattro mani di Pavese e della Calzecchi che gli “aveva prestato la grammatica”, nacque la famosa traduzione per Einaudi dell’Iliade.
La traduzione dell’Iliade
Come apprendiamo dalle lettere che Pavese invia al “Caro Professore” in quei mesi, la traduzione dell’Iliade aveva un chiaro obiettivo che per molti versi la avvicina ai Dialoghi: “Evitare il neo-classico, montiano o pascoliano che fosse [il corsivo è mio], ed evitare la vile prosa.” L’inneggiato movimento neo-classicista aveva, infatti, secondo Pavese distrutto la realtà delle parole e quella grandiosa unione fra immagini sublimi e quotidiane che rendevano il testo immortale, eppure familiare. Pavese si è ricordato di quand’era a scuola e di quel che leggeva: si è ricordato dei libri che legge ogni giorno, degli unici libri che legge.
Di nuovo l’intento dichiarato e perseguito era il recupero della realtà, non solo nelle immagini e nella divisione dei versi, ma soprattutto nella resa del greco che doveva essere letterale, quasi interlineare a qualsiasi costo. Per raggiungerla Pavese e Calzecchi non si fecero scrupolo ad utilizzare, dove necessario, anche altre lingue, ad esempio toujour per rendere HMATA PANTA.
Conclusioni
Dunque, sia quando sembra che si rifugi in un mondo di racconti e storie antiche, sia quando rema contro i colossi della sua epoca per far onore al primo poeta della nostra storia, Pavese rimane un incomparabile interprete della realtà. Anzi, uno dei pochi autori neo-realisti che a pochi anni dal tremendo suicidio, immergendosi a fondo nell’etica di tale movimento, ascolta davvero la voce della realtà direttamente dalle sorgenti della poesia.
Chissà se chi gli stava attorno non avrebbe dovuto ascoltare meglio quando scriveva:
“quest’è la beffa e il tradimento: prima ti tolgono ogni forza e poi si sdegnano se tu sarai meno che uomo. Se vuoi vivere, smetti di vivere…”
Noemi Ronci per Questione Civile


